|
di Enrico
Castelli Gattinara
Docente di
Epistemologia della Storia, Sapienza Università di Roma, Circolo Bateson.
 Arte e scienza: di solito è un dialogo fra sordi. L’artista usa a modo suo pezzi
di scienza che lo affascinano o gli sono congeniali, gli scienziati si occupano
di arte – quando se ne occupano – a tempo perso e certamente fuori del loro
ambito specifico di lavoro. Kuhn avrebbe chiamato incommensurabili i rispettivi
sistemi di pensiero e di riferimento paradigmatico, e certamente le loro
rispettive “pratiche” di lavoro. Arte e scienza: di solito è un dialogo fra sordi. L’artista usa a modo suo pezzi
di scienza che lo affascinano o gli sono congeniali, gli scienziati si occupano
di arte – quando se ne occupano – a tempo perso e certamente fuori del loro
ambito specifico di lavoro. Kuhn avrebbe chiamato incommensurabili i rispettivi
sistemi di pensiero e di riferimento paradigmatico, e certamente le loro
rispettive “pratiche” di lavoro.
Cosa c’è di più diverso del lavoro dell’artista (creativo) e dello scienziato
(sistematico e metodico)? Lo scienziato non può usare le cose come gli pare, ma
deve obbedire a dei protocolli procedurali molto rigidi: ha pochissimo spazio
per la creatività, la fantasia e persino per la curiosità. Ha pochi soldi da
buttare via, o da inutilizzare in un’opera d’arte (come per es. ha non-fatto
Paolo Monti con Denaro contante del 1991: parallelepipedo di banconote con
guardie armate in un’esposizione… mai realizzato). Il suo lavoro – in
laboratorio, per esempio – è spesso ripetitivo, iperorganizzato e rigido.
L’artista invece può fare come gli pare, può trarre ispirazione da qualsiasi
cosa, può permettersi di scegliere il metodo e gli oggetti che più lo
sollecitano (lo scienziato non ha questa libertà di scelta: la sua facoltà di
scegliere si esprime solo agli inizi, quando comincia una ricerca, poi le cose
devono seguire vie già preordinate e gli sviluppi devono essere prevedibili).
Può certamente lavorare con rigore, può usare metodo scientifico, può studiare
matematica e elaborare strutture frattali, come Paolo Monti ha fatto e sta
facendo… ma il suo lavoro non è vincolato in partenza, e i suoi vincoli devono
sempre poter essere spezzati e spiazzati (qui potremmo dire “spozzati”).
La differenza fra l’arte e la scienza è proprio questa: la libertà di contro
alla legge.
Che bello, sarebbe, se fosse tutto così chiaro e netto: senza legge non si vive,
e nessuno di noi lo vorrebbe (infatti ci arrabbiamo se qualcuno ci sfila il
portafogli in autobus, o se il commerciante non ci dà il resto giusto, se
qualcuno ci passa avanti in una fila, ecc.).
La legge dà certezza e sicurezza. Permette l’accordo.
Eppure nessuno di noi rinuncerebbe mai alla libertà, condizione essenziale per
vivere felici. A questo proposito i filosofi già dal XVII secolo discutevano sui
limiti fra la libertà individuale e la legge sociale, e sono nate quelle
bellissime frasi che recitano “la mia libertà finisce dove comincia la tua”, che
cercano cioè un’armonia fra il senso di libertà ritenuto innato nell’essere
umano (il che invece è da dimostrare, ed è fortemente connotato culturalmente) e
la necessità della legge, perché l’accordo di tutti con tutti non si trasformi
nella guerra di tutti contro tutti (Hobbes).
Ma qui siamo già fuori dall’arte e dalla scienza: come vedete, il discorso porta
verso altri orizzonti, crea nuove connessioni, nuovi sviluppi, nuovi problemi.
Diventa politico ed ecologio, etico e morale… Non è possibile confrontarsi con
l’opera di Monti senza aprirsi a questo infinito delle connessioni possibili,
poiché le cose che siamo e che lavoriamo non sono mai del tutto isolate dal
resto: tutto sta nel trovare-tracciare i percorsi giusti per passare da un piano
all’altro del discorso e del fare, del pensare e del vivere.
Se il rapporto fra arte e scienza si limita a una coabitazione, a un
compiacimento reciproco (gli scienziati ammirano l’arte, la ospitano, magari a
tempo perso la studiano o la praticano; gli artisti invece la usano, la
prendono, la buttano via ma non si sottomettono alla sua disciplina), il
problema arte/scienza resta banale e già risolto da sempre (o quasi): Leonardo,
Boccioni, Mondrian, Kandinski, Sergio Lombardo, ecc. Resta la differenza, ma non
la compenetrazione e l’organizzazione reciproca.
E invece già da Galielo sappiamo che le cose stanno in modo assai diverso,
perché arte e scienza vanno di pari passo non come due entità separate, ma come
una stessa entità, e necessitano l’una dell’altra: cosa sarebbe la scienza senza
creatività? E cosa l’arte senza metodo? Ma le cose sono assai più raffinate,
oggi. Perché non è questo ancora il problema. Il problema è quello di suscitare
inquietudini e interrogativi. E questo lo fanno sia l’arte che la scienza (in
modi diversi, ovviamente): rompere le regole per trovarne altre, infrangere la
legge in nome della legge (gli scienziati sono in fondo persone per bene, che
provano un grande gusto nel fare proprio questo, e perciò sono stati talvolta
malvisti dal Potere), limitare la libertà in nome della libertà. Usare il denaro
per provocare il denaro e mostrarne non l’aspetto di feticcio, ma l’aspetto di
merce. Il suo corpo, la sua consistenza. Senza per questo eliminare o escludere
il suo aspetto feticcio. Il lavoro di Monti sul denaro è un lavoro scientifico
assai più che artistico.
Occorre guardare alle cose con maggiore attenzione. Come al solito. Come per
tutto.
E superare le apparenze.
Da quando l’arte è arte, cerca di superare le apparenze e la superficie, ma lo
fa senza per questo eliminarla o dimenticarla (come invece ha fatto spesso la
filosofia). Parafrasando Nietzsche, si può dire che l’arte è superficiale per
profondità. Pensate a Caravaggio, alla sua rivoluzione dell’uso della luce e
all’irruzione della corporeità quotidiana nello spazio sacro della
rappresentazione. Il piede sporco di uno dei carnefici di san Pietro, i tratti
da popolana di una madonna, le unghie sporche, il ghigno, l’ironia, l’assurdità
che si ritrovano anche nei fiamminghi sono i caratteri di una realtà banale,
normale, apparente, che invece di fare da schermo ci deve introdurre verso ciò
che è più difficile da pensare e da capire. E’ l’idea dell’incredibile che è
dentro il credibile. Non il credibile che diventa incredibile, ma l’incredibile
del credibile. L’ironia di Arcimboldo insegna questo. Patate, carciofi, carote,
pere, mele, uva… dopotutto, la pop art ha inventato ben poco, verrebbe quasi da
dire: la superficie del mondo, la sua materia, è ciò che resta più misterioso ai
nostri occhi (anche agli occhi della mente). Questo il messaggio dell’arte. Non
“spingersi oltre”, ma imparare a stare meglio dentro ciò che per questa diversa
prospettiva si rivela assai più ricco di quanto si pensava.
Ecco allora che si può aprire una nuova strada per affrontare sempre gli stessi
problemi (quelli di capire e comprendere ciò che siamo e ciò in cui e con cui
siamo, il mondo che ci circonda e di cui siamo fatti): l’artista Paolo Monti che
si fissa su quello che usiamo forse più di ogni altra cosa nella nostra vita di
tutti i giorni, il denaro, e vuole ricomprenderne la materialità. Una
materialità che per definizione si è persa nell’esclusività del valore nominale.
Il valore del denaro è una cosa talmente banale che neppure ci sorprende, anche
se fluttua in maniera così instabile che è una meraviglia della complessità. Ma
tutti pensano al denaro come a un valore preciso di scambio definito da norme
monetarie ed economiche nazionali e internazionali di cui pochi conoscono i
meccanismi ma di cui tutti accettano volenti o nolenti i risultati. Ed è un
materiale che circola, viaggia: freneticamente.
Monti ha deciso di prendere il denaro sul serio, in particolare nella sua forma
materiale più materialmente volatile, la carta moneta. E per questo ha scelto il
denaro per eccellenza della modernità, il dollaro, il biglietto da un dollaro. E
su di lui ha operato dissacrandone il valore nominale, studiandone la
composizione fisico-chimica, provocandone le reazioni e alla fine – è l’opera in
corso che è TazebAu – sostituendo il valore proprio (one dollar) con un insieme
di valori altri che vi si intrecciano sopra (firme, tempo, percorso, altre
circolazioni).
La firma: ecco una connessione inaudita e incredibile. Personalizzare
l’impersonalizzabile. Il denaro non appartiene a nessuno, perché rappresenta lo
scambio perfettamente equivalente: tutti i biglietti di banca dello stesso
valore nominale si equivalgono, a milioni. La firma è invece il marchio
dell’individuo persona, il sigillo, the great seal, insostituibile e non
falsificabile (per legge!). Ma Monti non ha voluto fare quello che tanto diverte
gli adolescenti di 14 o 15 anni: marcare un biglietto da un dollaro con un
piccolo segno, una frase d’amore, un insulto, ecc. che poi circoleranno chissà
dove, e magari torneranno per un momento fra le mani di chi ha scritto (è quello
che in fondo si spera). Monti ha semicancellato il sigillo ufficiale, o lo ha
alterato, per metterlo in tensione con la firma in un viaggio che rappresenta la
circolazione di altre cose, e soprattutto di altri valori. Perché in questo suo
lavoro – ed è questa la sua inaudita intelligenza e la sua scientificità – il
denaro non viene negato in quanto denaro, in quanto simbolo che ha senso in
quanto portatore di un determinato valore rappresentato. Non si tratta di
eliminare o distruggere il denaro, ma di affidargli altri valori… e magari
continuare a farlo circolare, viaggiare.
Far entrare il mondo nel dollaro, e non più fare come si è sempre fatto, vale a
dire far entrare il dollaro nel mondo. La globalizzazione la viviamo tutti i
giorni. Paolo Monti la fa al rovescio (ma non al contrario): non priva il
dollaro del suo valore (perché quello resta pur sempre un dollaro), ma ne mostra
tutti i valori aggiuntivi virtuali che lo possono sottrarre – e di fatto lo
sottraggono – all’esclusività del suo destino monetario.
Mi chiedo: cosa c’entra tutto questo con un laboratorio di ingegneria
aerospaziale, che di dollari ne vorrebbe molti per portare avanti le proprie
ricerche, ma li vorrebbe “veri” e pieni di valore monetario? Che tipo di
connessione si è stabilita con Paolo Monti?
Per un verso è facile capire: l’artista viene qui per rompere un po’ le scatole,
per provocare, per continuare il suo lavoro di cercare nelle superfici del mondo
ciò che queste superfici rivelano di inesauribile e di incredibile. L’artista è
sempre affascinato dalla scienza, e la usa. Chiama un pezzo (una connessione)
della sua opera “Il satellite nel pozzo”, sfrutta il lavoro degli ingegneri per
le sue proiezioni, li spinge a lavorare con lui e per lui, sfrutta i loro spazi…
e si usa nel tempo (nel senso che usa e si lascia usare dal tempo che passa,
modificando continuamente la sua opera, come il tempo sempre già fa
inevitabilmente con tutto).
Per un altro verso invece le cose sono assai più complicate: perché gli
ingegneri hanno accettato quest’opera? Cosa vogliono dall’artista? In che modo
lo stanno usando e come ne stanno sfruttando le capacità? In che senso e in che
misura hanno compreso l’affinità fra il loro e il lavoro dell’artista? Cosa ci
stanno dicendo, senza dircelo apertamente?
 
Guardiamo allora all’oggetto principale dell’evento, il satellite: il pozzo sta
là da secoli a mostrare, senza dirlo a nessuno ma facendolo vedere a tutti, che
la superficie è sempre bucata e dotata di profondità da indagare, e il satellite
si specchia in questa profondità quasi per dire (questo il discorso tacito degli
ingegneri, non dell’artista) che un satellite non è solo un corpo morto, ma va
compreso nella sua materialità. Una materialità che fa giocare in s?materie
molto diverse fra loro, se ammettiamo che siano materia sia l’alluminio che il
tracciato di una curva sullo schermo di un computer. E infatti questo satellite,
unisat, che gira velocissimo in meno di due ore intorno al mondo, serve a
misurare se stesso, la materia (o meglio le materie diverse) di cui è fatto. Un
satellite inutile, insomma. Un giocattolo. Di nessuna utilità quotidiana. Non è
di quelli che servono per le nostre telecomunicazioni, per i gps, per i
telescopi, per le rilevazioni spaziali, per google, per i militari, ecc. Tutte
queste funzioni vengono operativamente inutilizzate. Il che significa
soprattutto (perché non c’è niente di male nell’inutilità, visto che è qualcosa
di sempre parziale e circostanziato, e quindi l’inutile è tale sempre e solo
rispetto a certi scopi, a non ad altri) che inutilizza il suo valore commerciale
immediatamente spendibile e monetizzabile. Serve infatti agli ingegneri per due
cose che sono terra terra, nel vero senso della parola. Servono a permettere
agli studenti, sulla Terra, qui ed ora, di costruire un satellite vero e
proprio, che va veramente nello spazio, e serve soprattutto – ecco dove sta il
trucco che accomuna questi ingegneri all’artista – a capire come reagiscono
nello spazio i materiali terrestri con cui è costruito e funziona. Materiali
terrestri, poveri, di tutti i giorni (le batterie, per esempio, o il tessuto per
gli aquiloni), del tutto superficiali. Questi ingegneri, che in tal senso sono
anche scienziati ma non per questo rinunciano al loro essere ingegneri
(materiali, appunto), hanno in un certo senso “slavato” il satellite da tutti i
suoi usi più prevedibili (e soggetti a lauti finanzamenti). A me pare: un po’
come i dollari di Monti. Questo satellite non serve a niente, se non a se
stesso; è un satellite introverso e non estroverso, narcisistico. E per questo
non può non affascinare chi non si limita a considerarlo semplicemente nella sua
superficialità. Certo, se le misurazioni sono interessanti e i materiali
reagiscono bene nello spazio, le ricadute economiche possono essere adottate
dalle industrie, qualcuno può farci bei profitti, qualcun altro può ricavarci
una bella pubblicazione sulle riviste più importanti del settore, ecc. Ma al
satellite non gliene importa nulla, di tutto questo. Il suo valore è un non
valore, un valore autoreferenziale: per questo “inutile”.
Ho suggerito che è questo un po’ anche il lavoro che P. Monti ha fatto sul
denaro. L’ha slavato. Ne ha grattato via tutta la nobile monetarietà simbolica.
Addirittura ne ha alterato il sigillo simbolico per eccellenza, l’aquila, che è
sugli stemmi delle divise spaziali degli astronauti, oltre che sui dollari e sui
timbri dei documenti ufficiali.
Ma c’è dell’altro: il satellite gira intorno al mondo – il suo riflesso sonoro
nel pozzo lo testimonia – e i suoi “proprietari” lo tengono costantemente
d’occhio in questa sua circolazione, come le banche tengono d’occhio la
circolazione del denaro. Ma un satellite inutile che circola in questo modo
assomiglia al viaggio dei dollari resi inutili dall’artista: portano entrambi
con sè una materialità che infrange e dissolve – slava – l’investimento
valoriale che li origina, circolano per altre strade, che pur essendo le stesse
di fatto non lo sono, e mostrano in questo modo che nella superficie c’è
un’alterità che non è facile cogliere, ma che occorre farlo se vogliamo imparare
a vedere le cose altrimenti. Caricare un satellite spaziale con sei semplici
pile torcia che si comprano dal tabaccaio significa caricarlo di una fonte di
energia povera e ricca di significato, analogamente alle banconote grattate e
trattate che circolano fra l’Italia e la Cina e che vengono caricate di firme e
sigilli, a testimoniare che l’umano non muore necessariamente di fronte
all’ineluttabile della tecnica e del mercato globale.
Discorsi pericolosi, che è difficile fare, ma che le cose trattate e slavate in
questo modo sono capaci di comunicare. Provocare le cose a reagire, e insegnare
alle cose e a noi tutti – agli studenti in primo luogo, ma qui lo diventiamo nel
momento in cui, come sempre, ci disponiamo a imparare qualcosa che non sappiamo,
e ci mettiamo alla ricerca, aprendoci allo stupore e allo studio, che non a caso
hanno una stessa radice fonetica - insegnare che il mondo è pieno di pozzi in
cui si specchiano i satelliti, ossia che è pieno di strade e percorsi inattesi
che ci possono portare oltre le apparenze e far risuonare fra loro cose anche
molto lontane fra loro. Ecco perché qui, oggi, arte e scienza hanno potuto
incontrarsi e parlarsi in maniera originale.
Roma, dicembre 2007
Enrico Castelli Gattinara - Docente di Epistemologia della Storia,
Sapienza Università di Roma, Circolo Bateson.
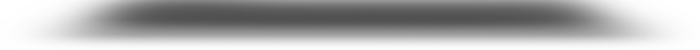
|
|
|
|
testi selezionati

▪
critici
Testi critici sulla trattazione del denaro nell'opera di Paolo Monti
tazebAu

▪
progetto itinerante
MUSIS
▪ Paolo Monti e TazebAu
TazebAu al Circolo Bateson
in moto da Venezia a Pechino, 2005
TazebAu messaggero di pace
un filo per. . .
TazebAu moneta relazionale
architettura delle
relazioni ambientali
TazebAu vettore di futuro
Lift▪off Sindone 21' 37", 2011
Coopartecipatori al progetto TazebAu
tazebAu
s'pace

▪
esposizioni
▪
workshops
▪
video installazioni
▪
immagini
▪
contatti
▪
links
|